Parlerò di tre autori, anzi ne riporterò per maggior chiarezza le pagine, i quali compiono il mirabile sforzo di entrare in contatto con gli altri o con l'altro, con realtà inconsuete, infrequentabili o strane. Prodigarsi in questo senso è a mio avviso uno dei significati della letteratura.
Il romanzo Sangue di cane di Veronica Tomassini (Laurana, Milano 2010, pp 230, e 16.00) è la storia dell'amore sconvolgente di una donna per un polacco alcolista che chiede l'elemosina a un semaforo. E' ambientato in una Siracusa metropolitana, ma potrebbe svolgersi alla periferia di qualunque centro abitato circondato da baracche di emarginati. I ripetuti tentativi della ragazza di salvare lo slavo sono occasione per rapportarsi con un mondo di esclusi, la cui presenza accanto a noi è segno di qualcosa che spesso ci rifiutiamo d'interpretare ma che inconsciamente fa appello a tutte le doti umane di comprensione e partecipazione. La scena di seguito descritta, che si svolge in prossimità di quelle grotte in cui trovano riparo i senza casa, evoca un mondo fuori dalla storia e pare svolgersi all'ingresso dell'inferno:
"C'erano le grotte dei polacchi e le grotte dei rumeni, rom rumeni di Sibiu o Valea Seaca, famiglie intere con bambini in fasce, bambini di tutte le età. Dividevate il territorio, da una parte i polacchi, dall'altra i rumeni. A pochi metri, sorgeva la chiesa degli ultimi giorni e un albergo a cinque stelle. Ma entrando in zona franca, il mondo bisognava dimenticarselo.
Era un'altra storia, una storia brutale. Mi venne incontro una donna, Wiga disse di chiamarsi, aveva dei graffi sulla fronte e promanava un insopportabile tanfo di vino, vino acido. Parlava bene l'italiano. 'Cosa tu cerchi?', chiese, bloccandomi l'accesso alla prima cava, una bocca nera e cupa, come le altre. La prima sulla destra, quella dove morì Rado. 'Sono Wiga, io devi lavorare, tu aiuti me'. Aveva i capelli di un biondo sbiadito, sporchi e tenuti a bada da una grossa molletta, corporatura minuta. portava pantaloni sudici e di un modello fuori moda e un maglione infeltrito beige, anch'esso fuori moda. Roba rimediata alla Caritas oppure obolo di qualche brava donna, una pia giudiziosa e affranta da tanta miseria e con un armadio da svuotare.
Mi guardavo intorno sperando di individuarti, siamo all'inferno, considerai impressionata, peggio che nella casa di via Nino Bixio. Dalle grotte, e si avvicendavano una dietro l'altra, arrivavano imprecazioni simili a rantoli, Realizzai che avevo scoperchiato il tombino più guasto, eravate almeno una cinquantina, eccoli gli uomini delle grotte, uomini dell'est, sospirai, trattenendo un conato. Woitek, Stanislaw, Andrzej, Bogdan, Ula, Wisia, Tereza, Zitka, Celina, Zosia, ne conoscevo qualcuno, erano gli stessi topi del parco, ratti dilatati. Ne uscivano a gruppi di tre, cadaveri tutti, anche se respiravano. Così provai ad addentrarmi nella bocca cupa e piena di fumo, al centro del meraviglioso parco della balza. Non ti vidi. Una donna sedeva all'entrata, i piedi deformati, nudi, rossastri, tu mi dicesti in seguito che era già nell'altro mondo, cirrosi, la sua, all'ultimo stadio. Il suo nome era Kasha, Kasia, qualcosa del genere, ma teneva duro, mi spiegasti, voleva vivere, a modo suo, in quella bocca nera e putrida, con tre uomini a terra che forse morivano o forse dormivano, che non avevano gambe, che non muovevano braccia. La donna aveva il viso carnoso e le unghie rigate di sangue. Dal viottolo si arrivava presto. Individuai la prima grotta, subito appresso la roccia dove era morto Rado perché aveva freddo. 'Dov'è Slawek?', domandai alla donna che diceva di chiamarsi Wiga, sentendomi debole come non mai. (…)
Nell'aria si spandeva il marcio della morte, della depravazione, del male, qualcosa che non riuscivo a tradurre, alcol vomitato, forse, un miasma lugubre, sulfureo mi piegava la schiena, le donne aspettavano timorose una reazione, la mia presumo, loro nel frattempo piangevano." (p 109).
Tomassini, al suo esordio, si annuncia come un'autrice che ha il coraggio e la necessaria ambizione di parlare coi dannati, o presunti tali.
Un'immagine apocalittica da fine del mondo, ma anche da oltremondo, è rappresentata da un'installazione realizzata per la Tate Modern di Londra nel romanzo Dublinesque di Enrique Vila-Matas (Feltrinelli, Milano 2010, pp 250, e 18.00), romanzo dove un editore letterario europeo in pensione si picca, con alcuni vecchi amici scrittori, di celebrare a Dublino, in occasione dell'ultimo Bloomsday, il funerale della gloriosa era di Gutemberg, l'era del libro stampato ormai alla fine.
Questa, una pagina altamente suggestiva:
"Intuisce che dimenticherà presto Londra, ma non la brillante installazione di Dominique, che ha visto con i suoi genitori e con Celia alla Tate Modern. Fu un'esperienza ai limiti della ragione perché i suoi genitori la presero in modo molto letterale e vi scorsero, con il naturale stupore, la fine del mondo, cosa che li lasciò a lungo impressionati e muti.
Pioveva con particolare violenza e crudeltà fuori dall'installazione, mentre all'interno di essa alcuni altoparlanti si facevano carico di riprodurre artificialmente il rumore della pioggia. E quando stavano già per andarsene da quel riparo per i sopravvissuti alla catastrofe, si riposarono un momento sui letti a castello di metallo che accoglievano, giorno e notte, rifugiati del diluvio del 2058, anno in cui, senza dubbio, tutte le persone che Riba ha amato, tutte senza eccezioni, saranno morte.
Quell'anno tutti i suoi cari staranno dormendo per sempre, dormiranno nello spazio infinito della dimensione sconosciuta, uno spazio trasformato in rappresentazione ultima della pioggia che sferza i vetri delle finestre più alte dell'universo. Non c'è alcun dubbio. Nel 2058 tutti i suoi amati saranno come quelle finestre alte delle quali parlava il poeta Larkin: finestre che assorbivano il sole e in cui, al di là, l'aria azzurra e profonda non mostrava nulla, non era da nessuna parte, non aveva fine.
L'alta fantasia è il luogo in cui piove sempre, approfittò per ricordare lì a Londra, in mezzo a quell'atmosfera generale di grande catastrofe e di diluvio universale. Nell'installazione di Dominique si vedevano dappertutto repliche umane di Spider e numerosi esempi di fantasmi ambulanti e uomini addormentati. Sua madre ordinò un infuso sulla terrazza belvedere dell'ultimo piano della Tate, mentre suo padre non smetteva di mostrarsi sorpreso.
'Vi siete resi conto di quello che abbiamo visto? Siamo in piena fine del mondo!' ripeteva tra l'allegro e il molto compunto mentre contemplava l'ampio panorama di Londra sotto la pioggia spettacolare e devastante.
Allora, con un grande senso di umorismo involontario, sua madre, dopo essersi ripresa grazie al tè che le servirono al posto dell'infuso, disse a suo marito in un impeto di subitanea preoccupazione: 'Smettila di ridere, Sam, e renditi conto, una volta per tutte, di quel che succede. Nelle ultime settimane ha sempre piovuto. Non può essere vero che piova così tanto. A Barcellona, a Londra, tutto il tempo. Credo che persino nell'Aldilà piova sempre.'
E poi, come se fosse giunta alla conclusione più importante o forse solo alla più ovvia della sua vita, aggiunse: 'Sospetto che siamo morti'." (p 208).
Infine, un incipit che ha del meraviglioso. Siamo alle prime battute del romanzo Abbacinante di Mircea Cartarescu (Voland, Roma 2007, pp 375, e 20.00) e fin dall'inizio l'autore ci conduce, come per mano, nel mondo dei suoi sogni.
"Mi sentivo davvero me stesso soltanto a luce spenta. Improvvisamente cominciavano a roteare sui muri i raggi blu elettrico e verde fosforescente dei tram che passavano sferragliando in strada, cinque piani più sotto, d'un tratto prendevo coscienza della solitudine e della tristezza infinite della mia vita. L'interruttore era dietro l'armadio; appena spegnevo, la stanza diventava un livido acquario. Navigavo come un vecchio pesce fra mobili putridi che parevano rottami scaraventati dal mare sugli scogli, camminavo sul tappeto di iuta, ruvido sotto i piedi nudi, fino alla cassapanca e mi ci sedevo, rimettevo i piedi sul termosifone e allora una Bucarest fantastica esplodeva improvvisa dietro i vetri azzurrati di luna. Un trittico notturno, scintillante e vetroso, infinito, inesauribile. Di sotto vedevo una porzione di strada, con i pali elettrici simili a croci metalliche e le lampade rosa che d'inverno cacciavano fuori dalla notte nugoli di fiocchi di neve lenta o furiosa, rada come nei cartoni animati o fitta come una pelliccia. (…)
Dalla parte del Circo di Stato, l'edificio con il supermercato e un altro chiosco, quello dei giornali. Proprio lì, nei miei sogni, hanno inizio i sotterranei. Con un cestello di fil di ferro intrecciato mi aggiro fra confezioni di marmellata e serbet, fra rotoli di carta igienica e sacchetti di zucchero (in cui a volte erano nascoste automobiline di metallo verdi o arancioni: o almeno così dicevamo fra noi bambini); poi, spingendo una porta a due battenti, mi inoltro in un'altra zona del negozio che non è mai esistita e, stringendo ancora il cesto pieno di scatolame e vasetti, mi ritrovo fuori, sotto le stelle, dietro l'edificio, fra mucchi di cassette della frutta, di fronte alla porta di ferro dipinta di bianco dove a volte vendevano il formaggio. Adesso però ci sono una decina di porte, da un capo all'altro dell'edificio, e nemmeno una è come nella realtà; fra una e l'altra, le finestre vivacemente illuminate delle stanze del piano ammezzato. In ognuna si vede uno strano letto, dalle gambe altissime, e nei letti dormono ragazze bellissime coi capelli sparsi sui cuscini e i piccoli seni scoperti. In uno dei sogni aprivo la porta più vicina e scendevo per una scala a chiocciola che portava nelle profondità di un'alcova dove mi aspettava, sotto la luce elettrica, una di quelle ragazze-bambola riccioluta e docile. Ero già un uomo quando feci questo sogno, eppure non riuscii a possedere Silvia, tutta la mia eccitazione si arenò in un intreccio impastato di parole e gesti. La presi per mano per attraversare la strada innevata e le guardai i capelli turchini illuminati dalle luci della farmacia e del ristorante Horia, poi aspettammo insieme il tram, sotto la neve che ci cancellava i tratti del volto, e il tram arrivò, non c'era sopralzo sul telaio, solo qualche sedile di legno, Sivia salì e si perse in una zona della città che conobbi in seguito, in altri sogni." (p 9).
(17-12-10, sito del Primo amore)
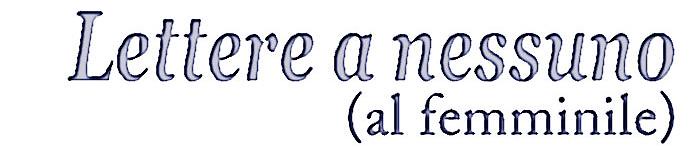
Nessun commento:
Posta un commento